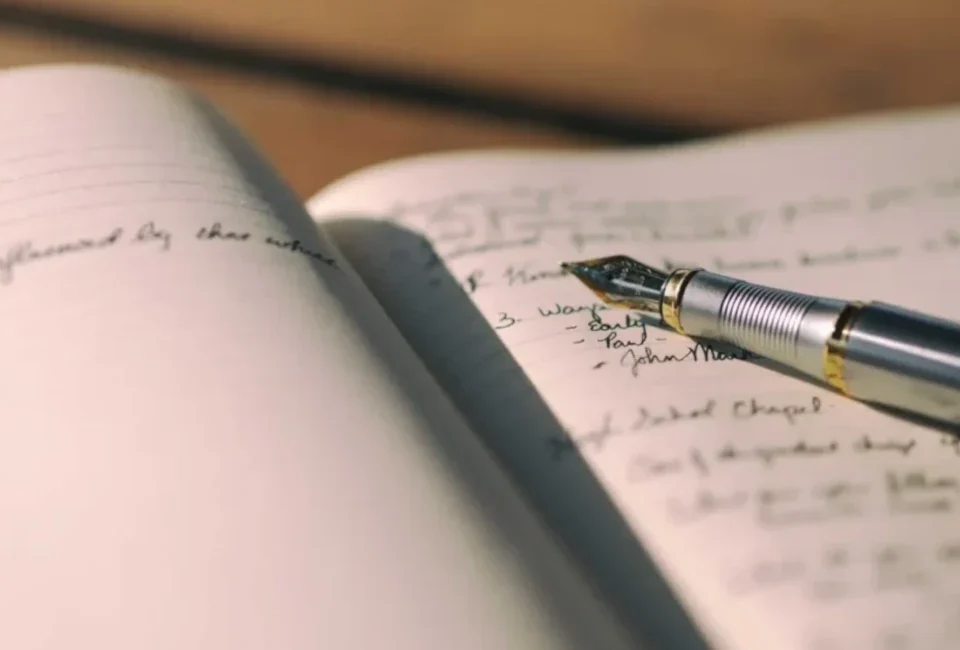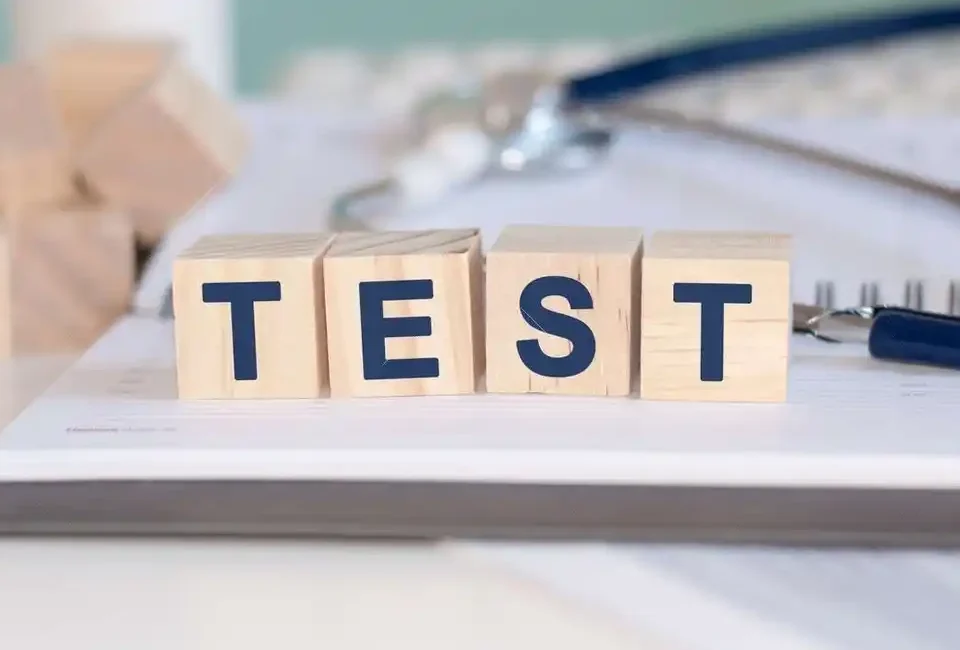ULTIMI ARTICOLI DAL BLOG
02/03/2024
Ci si conosce solo attraverso l’analisi della propria scrittura. Farsi fare un’analisi grafologica della propria scrittura permette un profonda conoscenza di se stessi, consente di conoscere […]
20/11/2023
Questo test misura il grado di narcisismo. Il test sul narcisismo si basa sulla premessa che il narcisismo non è necessariamente un fenomeno patologico, ma può […]
15/04/2019
Il love bombing è l’arma del narcisista per soggiogarvi. Questa tattica viene usata da tutti i narcisisti per farvi innamorare di loro e potervi così manipolare. […]
13/04/2019
La triangolazione è una tecnica manipolatoria dei narcisisti. La triangolazione si caratterizza per l’introduzione di un terzo elemento all’interno di una diade, di una coppia, con […]
11/04/2019
Il gaslighting è una crudele e subdola tecnica manipolatoria. È un percorso di manipolazione con l’obiettivo di far dubitare la vittima della propria lucidità mentale. Si […]
12/03/2018
Lo scarto del narcisista è l’abbandono della sua vittima. Viene chiamato “scarto” perchè il narcisista non pone fine alla sua relazione come una persona normale, lui […]
10/04/2024
Il narcisismo e la codipendenza hanno molto in comune. I dipendenti affettivi vengono descritti come vittime che cadono preda di coloro che hanno tratti narcisistici. Questa […]